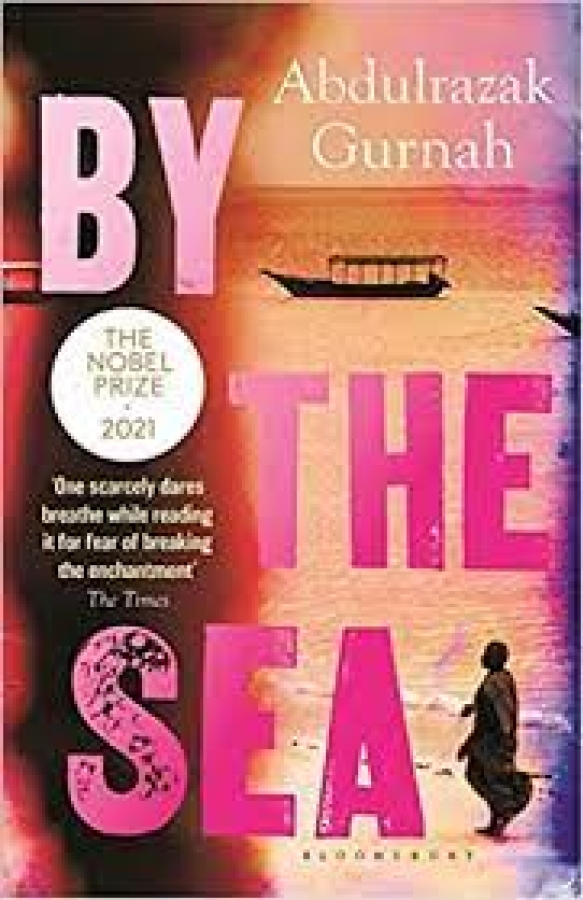"Il mio nome è Rajab Shaaban. Non è il mio vero nome, ma l'ho preso in prestito. (...) Apparteneva a qualcuno che conoscevo molti anni fa". Già da questa frase, che introduce uno dei due protagonisti, possiamo cogliere alcuni tratti distintivi del romanzo: la bugia, come sotterfugio e gusto di raccontare storie; il destino e l'assoluzione dalle colpe perché Shaaban è l'ottavo mese dell'anno, "quando sono decisi i destini dell'anno che viene e i peccati del vero penitente sono assolti"; la fuga dalla memoria, "prima che essa diventi così solida da tenerci in pugno e sovrastare ogni altro pensiero". Siamo pure dinanzi a un crocevia di civiltà e lingue: Shaaban è in Inghilterra e parla inglese, il luogo e la lingua del colonizzatore, proviene da Zanzibar e dall'Africa Orientale ma tutto il racconto è impregnato di cultura araba e della vicina India meravigliosa. Shaaban ha finto di non conoscere l'inglese, c'è bisogno di un interprete ed è interpellato Latif, un giovane professore di letteratura, pure lui originario dello Zanzibar. Si dà il caso che il padre di Latif si chiami come Rajab Shaaban; è una coincidenza o dietro a questo nome si nasconde qualcun altro, forse persino Saleh Omar, che ha portato la sua famiglia alla rovina? Il lungo colloquio tra Shaaban e Latif, dal titolo indicativo di "Silenzi", è preceduto da due parti propedeutiche. La prima, "Relitti", narra l'arrivo di Shaaban in Inghilterra, la spoliazione della cultura di origine e del suo passato, come un vecchio mobile, residuo inutile di una vita che non c'è più e non potrà tornare. Non bisogna lasciarci ingannare dal fine ritratto ironico della società inglese né dalle considerazioni sul colonialismo britannico: i temi sono lo spaesamento e la rimembranza. Nella misera stanza della casa di accoglienza c'è uno specchio, "troppo largo in quella piccola camera buia, (...) in quella luce opprimente, la mia immagine riflessa pareva quella di una creatura sospesa in una crescente oscurità, il cerchio della luce che s'infilava nell' ombra, incombente sulle mie spalle come un nodo scorsoio non stretto". Ma l'oscurità gli era preziosa perché era piena di "mormorii e sussurri" mentre prima (i rumori) erano stati così paurosamente evidenti. (...) I momenti scivolano tra le dita. Anche se li racconto a me stesso, posso sentire gli echi di ciò che sto sopprimendo, di qualcosa che ho dimenticato di ricordare." La seconda parte si caratterizza sin dal titolo per realismo narrativo: Latif è il nome con il quale viene chiamato il giovane nella Germania dell'Est, dove è andato a studiare, fuggendo il declino sociale ed economico della famiglia. In modo lucido e quasi distaccato Latif racconta le vicende della famiglia: il padre inetto e ingenuo, la madre che usa la propria bellezza per intrecciare scandalose relazioni amorose, l'affetto per il fratello maggiore e la sua perdizione sino alla scomparsa, e la figura di Hussein, personaggio mefistofelico, manipolatore e furfante. E' una società commerciale, fatta di affari, traffici, trattative, di sali e scendi, dove occorre essere accorti e dove la reputazione è fondamentale. Prosperoso transito di commerci tra l'India e il mondo arabo mussulmano, Zanzibar è travolto, e impoverito, dall'opprimente e ottuso dominio britannico; eppure resiste, sempre alla ricerca di nuovi commerci e fonti di ricchezza. Non saranno i colonialisti a travolgere la famiglia di Latif, saranno le rivalità familiari, gli inganni di Hussein e la bramosia di rivalsa patrimoniale di Saleh Omar, agli occhi di Latif il vero colpevole. Eppure, in questo lungo racconto sociale s'introduce qualcosa di magico. Nella razionalista Germania dell'Est, nella culla del marxismo leninismo, Latif è stato ingannato: credeva di avere avuto un legame epistolare con una giovane tedesca, ma scopre che è una signora cinquantenne, che ha costruito delle storie, desiderosa di sognare e raccontare qualcosa di inconsueto. Ed eccoci alla parte fondamentale del romanzo. Latif va da Shaaban per capire cosa è successo, "per completare quelle storie che mancano, (...) come un bambino o qualche cosa di simile, quando i tuoi genitori ti dicono cosa facevi e dicevi, e non hai nessuna memoria di ciò". Tuttavia "alcune cose non vale la pena conoscere." E perché Shaaban accetta di narrare? "Avevo bisogno di essere liberato. Non di essere perdonato e di essere pulito dei miei peccati. (...) Avevo bisogno di essere liberato del peso di eventi e di storie che non ero stato capace di dire, e che dicendo avrei colmato il forte desiderio che io sentivo di essere ascoltato e compreso". Shaaban non è interessato a dire la verità, anzi la sua narrazione dei fatti lo trasforma da colpevole a vittima, destabilizzando Latif. Shaaban ha bisogno di dire storie, come i narratori di "Le Mille e una notte" (si veda recensione in questo sito), come "Bartleby lo scrivano" di Herman Melville, " l'imperturbabile autorità della sconfitta di quell'uomo, della nobile futilità della sua vita": un fabbricatore di parole insomma. Come nell'Odissea (si veda recensione in questo sito), il lettore non si chiede più se Ulisse racconti la verità o menta spudoratamente: ci si lascia scivolare nell'incanto del racconto, in un mondo affascinante e magico di litigi familiari, di amori e tradimenti, di affetti perduti e di vendette, fino a che il povero Latif perde ogni certezza sul proprio passato; solo così è possibile iniziare una nuova vita, dimenticare di ricordare.
E' un errore inseguire la trama, cercare inutilmente di ricostruire la storia, di mettere ordine ai personaggi e ai legami reciproci. Per apprezzare il romanzo bisogna lasciarsi trascinare dalla fluidità della narrazione, come quando, in un mare splendido, salino e profondo, ci si lascia guidare dalle correnti, solo talvolta nuotando per riprendere la direzione. Come nei Canti Orfici di Dino Campana, il racconto gira e rigira su se stesso, abbandona e riprende, vede lo stesso episodio da differenti punti di vista; solo talvolta apre delle parentesi sulla storia e sulla società, ma non è quello che interessa; ciò che preme all'autore è parlare dei fascini e dei pericoli della rimembranza, della necessità di abbandonare la memoria, come cronaca di ciò è stato, per inoltrarsi nel presente. A questo scopo è pure utile la bugia. Il difetto del romanzo non è la confusione o la frammentazione; è che alla fine è così lungo da divenire prolisso e ridondante.
La contaminazione della lingua inglese può avvenire in tanti modi. Si pensi a Nadime Godimer, al grande Achebe (si veda la recensione di "Things fall apart") e ad Adichie Chimamanda ("Half of a Yellow Sun" in questo sito) in cui le lingue locali si innervano in quella inglese, che mantiene la sua compostezza pur arricchendosi di un nuovo lessico; alla talentuosa Bulawayo Noviolet che passa agevolmente dall'inglese dello Zimbabwe a quello gergale degli adolescenti americani (si veda "We need new names"), e infine al dannunziano Ruschdie Salman, con i suoi neologismi magnificenti (si veda il suo capolavoro "Midnight's Children" sempre in questo sito) . In Gurnah ci troviamo dinanzi ad uno stile elegante e pulito, che trova proprio nella fluidità del narrare l'impronta dell'arabo e delle lingue africane orientali.
Perché leggerlo? è bello farsi catturare, un po' troppo lungo.